scarica l’app per il tuo dispositivo android
le immagini che permettono di visualizzare i nuovi oggetti 3D con la APP AR (BYOM)
Museo Civico Gaetano Filangieri
![]()
Victa
1880 circa, Marmo, cm 70x56x29,5 Inventario numero 393

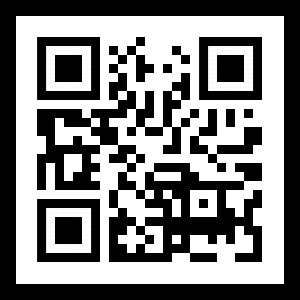
La Victa è un’importante opera realizzata, a partire dal 1880, dallo scultore Francesco Jerace. Nello stesso anno fu presentata al pubblico durante la IV Mostra Nazionale d’Arte di Torino, assieme ad altre sei sculture tra cui marmi, gessi e bronzi. Essa fa parte di quella lunga serie di busti femminili (muliebri) figli della fantasia dello scultore e da lui definiti “ideali” poiché nati da un’idea o da un sentimento, come Maja, Era di Maggio, Arianna, Ercolanea, Myriam e molti altri.
All’Esposizione di Torino la Victa ebbe un grande successo divenendo il modello apripista di un nuovo filone scultoreo, quello del busto-ritratto in cui il bello si univa al vero. Tale filone fu seguito da molti artisti che realizzarono opere chiaramente ad esso ispirate, tra cui si ricordano la Petroliera di Giacomo Ginotti, Frangar non flectar di Dante Sodini e la Vinta di Gaetano Chiaromonte. In risposta a una politica internazionale aggressiva, che vedeva la Polonia drammaticamente divisa tra le potenze di Austria, Prussia e Russia, la Victa, secondo la professoressa Isabella Valente, rappresenta allegoricamente la «Polonia vinta ma non domata».
Dal punto di vista stilistico, questo busto jeraciano fu il risultato di un’accurata ricerca avente come scopo la nascita di una nuova bellezza, nella quale i caratteri tipici del realismo venivano a fondersi con quelli di un classicismo di stampo michelangiolesco. La figura rappresentata è a un tempo sia donna vera che statua divina, è carne e marmo, finito e infinito. Il suo sguardo di sfida è espressione di un intenso studio psicologico, mentre la modellatura levigata del corpo, reso con fedeltà mimetica, rievoca una morbidezza quasi palpabile che si unisce al concetto di antico, manifestato dall’interruzione forzata del busto, sbozzato grossolanamente al di sotto del seno come se fosse un frammento archeologico. Jerace riprese la tecnica del busto sfrangiato dal suo maestro, lo scultore Stanislao Lista (che la utilizzò modernizzandola attraverso l’uso del non finito, facendo di essa un topos della scultura del secondo Ottocento), rivalutandola però nella funzione di archetipo classico.
In questo ritratto di donna attraente e impetuosa, così come in tutto il corpus delle opere jeraciane, si riassume formalmente l’enunciato desanctisiano secondo il quale l’ideale senza il reale manca di vita, il reale senza l’ideale manca di bellezza pura. Di questa importante opera Jerace eseguì circa diciotto versioni, alcune con delle varianti significative rispetto al modello originario esposto a Torino nel 1880, come la Victa di Sorrento, custodita presso il Museo Correale di Terranova, interrotta al di sotto delle spalle e ammirabile presso la loggia al secondo piano dell’edificio musealizzato che un tempo fu l’abitazione prediletta dei fratelli Alfredo e Pompeo Correale. Tra i modelli a mezzo busto, si conservano a Napoli due versioni: una esposta nella Sala Carlo V del Museo Civico di Castel Nuovo e l’altra qui al Museo Filangieri. Come per altri esemplari di tale soggetto, anche per la Victa della collezione Filangieri resta l’incognita dell’anno di realizzazione, perché, pur firmandoli a tergo, lo scultore non sempre vi appose la data. Ciononostante è possibile inquadrare la nostra versione in uno specifico arco cronologico che va dal 1880 al 1888, poiché fu tra le opere ammirate dalla folla di curiosi nel giorno dell’inaugurazione del Museo Civico Filangieri, avvenuta nel 1888. All’epoca la Victa era posizionata su una base in portovenere, marmo nero di grana fine con venature dorate o bianche, che si ergeva su un sostegno in legno di noce, decorato con bassorilievi inseriti in formelle, ed era esposta (come oggi) al piano terra del museo, pronta ad ammaliare e intimidire gli sguardi dei visitatori. Come si evince da uno dei verbali del Consiglio di Vigilanza del museo redatto nel 1907 al fascino della nostra Victa non fu immune nemmeno il suo stesso autore, che dimostrò, per questa versione, una particolare attenzione. Anche Filippi nel 1880 disse: « la Victa, che si potrebbe assai meglio chiamare Victrix, non è l’opera più importante dell’esposizione, né lo può essere, ma, a mio debole avviso, è la più perfetta».
Oggi, questo splendido busto di donna continua ad accogliere tanti visitatori che, come quelli del passato, ne restano conquistati.
Testa di fanciullo
terracotta invetriata, centimetri 28x20x17, Provenienza: collezione Filangieri. Inventario numero 2088


L’opera compare nel Catalogo, datato 1888, del museo come lavoro sicuro di Luca della Robbia anche se manca nelle maggiori monografie novecentesche su di lui e, al di là di alcune menzioni in testi relativi al museo stesso, sarebbe rimasta per lo più sconosciuta agli studi per quasi un secolo, fin quando Roberto Pane nel 1975, nei suoi volumi sul Rinascimento meridionale, la citò attribuendola ad Andrea della Robbia e suggerendone implicitamente un’origine dalla villa alfonsina di Poggioreale: del tutto improbabile in quanto i lavori della villa cominciarono non prima del 1487, troppo tardi rispetto alla cronologia più verosimile del manufatto.
Un primo segnale di più largo interesse si ebbe negli anni Ottanta del Novecento, quando Giancarlo Gentilini, artista italiano del 1900, attribuì nuovamente la terracotta a Luca, datandola per ragioni stilistiche al 1445 circa, e ritenendola parte del monumento funebre di Pietro d’Aragona, amato fratello di Alfonso V d’Aragona detto il Magnanino, sepolto nella chiesa di San Pietro Martire a Napoli. L’errata tradizione storiografica che vede Pietro destinatario di un monumentale sepolcro partenopeo, nata da un passo di Vasari già presente in un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Firenze (l’Anonimo Magliabechiano) ha creato non poca confusione. C’è da considerare, però, che un monumento del genere, più che essere interrotto nel 1447 a causa delle prime ostilità tra Napoli e Firenze, o essere stato realizzato ma distrutto nel terremoto del 1456, difficilmente avrebbe trovato posto in quella chiesa domenicana. Ciò perché lo spazio sacro più prestigioso dell’edificio, l’unico sufficientemente degno di accogliere Pietro, era già occupato dalla tomba di Cristoforo di Costanzo, gran siniscalco della regina Giovanna I (1343-1381), morto nel 1367 e ivi sepolto in quanto finanziatore proprio dell’area presbiteriale. Quando Alfonso nel 1439 contrattò con i frati per collocare nella tribuna la tomba di Pietro, quelli, per preservare la sepoltura del loro munifico amico, cercarono di dissuadere il re, suggerendogli provocatoriamente di spostare altrove il tumulo del Costanzo. Ciò permise ad Alfonso di mostrare la sua proverbiale magnanimità: non potendosi far torto a un defunto tanto illustre, avrebbe scelto per Pietro una sepoltura meno sontuosa, cioè una cassa lignea decorata con broccato nei pressi del Costanzo; una tomba del tutto simile spettò, qualche decennio dopo, a Isabella di Chiaromonte (morta nel 1465), moglie di Ferrante I. Successivamente i cadaveri di Pietro e Isabella furono collocati in una “cassa di marmo”, e ciò avvenne sicuramente prima del 1560, quando il doppio sepolcro era già riportato da un cronista cittadino. Va poi detto, seppur in termini suppositivi, che se il monumento fosse esistito davvero, almeno per qualche tempo, difficilmente se ne sarebbe perduta del tutto la memoria. Ma tornando ai dati cronologici va considerato che Gentilini ha notato che esiste una forte prossimità stilistica tra la testa della Vergine nel gruppo della Visitazione per l’altare della Compagnia di Santa Elisabetta in San Giovanni Fuor Civitas a Pistoia e il pezzo in esame. Le iridi grigio-azzurre (che in Andrea della Robbia diventano per lo più gialle), l’assenza della caratterizzazione delle sopracciglia, le labbra appena dischiuse e l’incredibile dolcezza dell’incarnato, testimoniano con evidenza che il pezzo napoletano e quello pistoiese appartengono agli stessi anni. Inoltre, se i capelli della Vergine sono bianchi, così com’era solito per le figure sacre, quelli castani della testa napoletana suggeriscono la naturalezza tipica di un ritratto, forse il primo della produzione robbiana.
Per quanto riguarda la collezione del Museo Civico, è importante notare che la Testa non è mai
menzionata nei documenti di Gaetano Filangieri precedenti al catalogo stampato per l’apertura del suo museo.
Se ne deduce, pertanto, che la Testa di fanciullo dovette entrare nelle collezioni Filangieri soltanto a ridosso del 1888, anno in cui Palazzo Como apriva le sue porte al grande pubblico. Sembra allora plausibile, come sostenuto da Luca Manzo, che la provenienza dell’opera vada ricercata in un contesto diverso da quello partenopeo, magari negli ambienti del mercato d’arte europeo così tipici delle frequentazioni filangieriane. In conclusione, va detto che tra il gennaio 1999 e il luglio 2001 la testa è stata sottoposta a un lungo intervento di restauro dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.
Elmo

QR-Code in preparazione
Nella ricca e varia collezione che Gaetano Filangieri ha voluto riunire in Palazzo Como a Napoli, le armi occupano un posto di non secondario rilievo. Già entrando nel magnifico salone al piano terra del museo ci si trova in presenza di un numero considerevole di manufatti ben disposti lungo i muri perimetrali, a vista, o in ordinate vetrine a parete. L’allestimento odierno non si allontana di molto da quello probabilmente voluto dal Principe, fatte salve le mancanze dovute agli eventi dell’ultima guerra, che hanno privato la collezione di numerosissimi oggetti. L’incendio appiccato il 30 settembre del 1943 dai guastatori tedeschi, poco prima del loro ritiro da Napoli, al deposito di Villa Montesano a San Paolo Belsito, dove erano state ricoverate per motivi di sicurezza le collezioni del Museo Filangieri, insieme ai documenti preziosissimi dell’Archivio di Stato, ha provocato danni ingenti all’intero patrimonio museale. Probabilmente anche le fasi successive alla ricollocazione degli oggetti nella storica sede di via Duomo, forse nella confusione generale postbellica, sono state segnate da sottrazioni non documentabili. Danni di guerra, ma non solo: è incolmabile la perdita di pezzi importanti come la spada alla spagnola dello spadaio napoletano Antonio Cilenta, arma appartenuta a Ferdinando II e passata al Principe per una scommessa vinta contro il monarca. Difficile, crediamo, che una lama temprata in fucina a temperature altissime si sia fusa nell’incendio di San Paolo Belsito, mentre le altre spade coeve presenti nella collezione sono pervenute a noi pressoché intatte. Certamente qualcosa si è “persa per via”.
Resta comunque un numero più che abbondante di manufatti per poter comprendere lo spirito con cui Filangieri ha organizzato la sua collezione. Uomo coltissimo, amatore delle arti, legato comunque, com’era nello spirito del tempo, a una visione estetizzante che spesso portava a riadattare o rifare qualche manufatto per ‘chiudere’ una serie, un oggetto incompleto.
Il lessico utilizzato per il Catalogo a stampa è quello del suo tempo, generalmente accettabile, fatti salvi errori rilevanti, legati soprattutto alla individuazione della provenienza dei pezzi mediorientali e dell’Estremo Oriente.
Il Principe ama collezionare, insieme alle armi occidentali, katane e naginata giapponesi, spade cinesi (Jian da cerimonia), katar indiani, shamshir mamelucchi, yatagan balcanici, zagaglie africane, kandjar persiani e caucasici, e via elencando. Filangieri qui si comporta più da appassionato collezionista e da amatore di armi esotiche che da studioso.
Nelle schede del Catalogo del museo appare evidente la sua modesta conoscenza delle cose di Cina e Giappone: le bellissime naginata giapponesi, che fanno mostra di sé nelle vetrine del piano terra, vengono prese per armi in asta cinesi; e così per le due armature da samurai, che il principe ritiene «modello di tutto tondo di un uomo d’arme cinese nel suo completo abbigliamento di guerra». E lo stesso discorso vale per le katane presenti, che egli definisce Yatagan cinesi, e per il moschetto a miccia giapponese, il tepp (Tanegashima-tepp ).
Eppure aveva visto le collezioni di armi orientali a Parigi, come lui stesso narra: «Per le armi cinesi poi, la raccolta che se ne vede al Museo d’Artiglieria a Parigi è la più completa e svariata che n’esista in Europa, avendo i francesi avuto occasione nella guerra contro il celeste Impero».
Non sappiamo quanti pezzi della sua collezione orientale siano stati comprati sul mercato parigino, forse il più ricco d’Europa. Resta comunque traccia, fra le sue carte, di un rapporto commerciale con la grossa ditta LeBlanc-Granger & Gutperle, specializzata nel rifacimento di parti d’armature, armi, costumi di scena, e consimili.
Nell’archivio del Museo Filangieri è stata ritrovata da Luca Manzo una lettera, datata 22 ottobre 1886, e più precisamente una fattura inviata al Principe per il rifacimento di parti di una balestra, compresi alcuni nuovi decori in avorio, dodici barattoli di grasso per ungere le armi e tre metri di tela smeriglio. E chissà che non si sia servito della stessa officina francese per aggiungere a una bella borgognotta bresciana cinquecentesca (inventario numero 507) i due guanciali mancanti.
In quel periodo, comunque, l’Italia e l’Europa sono piene di artigiani in grado di rifare armature intere da capo a piedi, come il vecchio armaiolo di Federico Stibbert, Giovanni Nizzero, il fiorentino Gaetano Guidi, il milanese Giuseppe Gaggini.
Il Principe alterna alle schede di catalogo ampie note esplicative, redatte per alcuni manufatti che ritiene di maggior rilievo, note tecniche e storiche, come quella sulle armi a Napoli durante la signoria borbonica, che forniscono importantissime notizie su armaioli, fabbriche, manufatti di particolare rilievo, come quelli decorati in acciaio faccettato, tipici degli anni a cavallo tra fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo.
Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino

protome equina

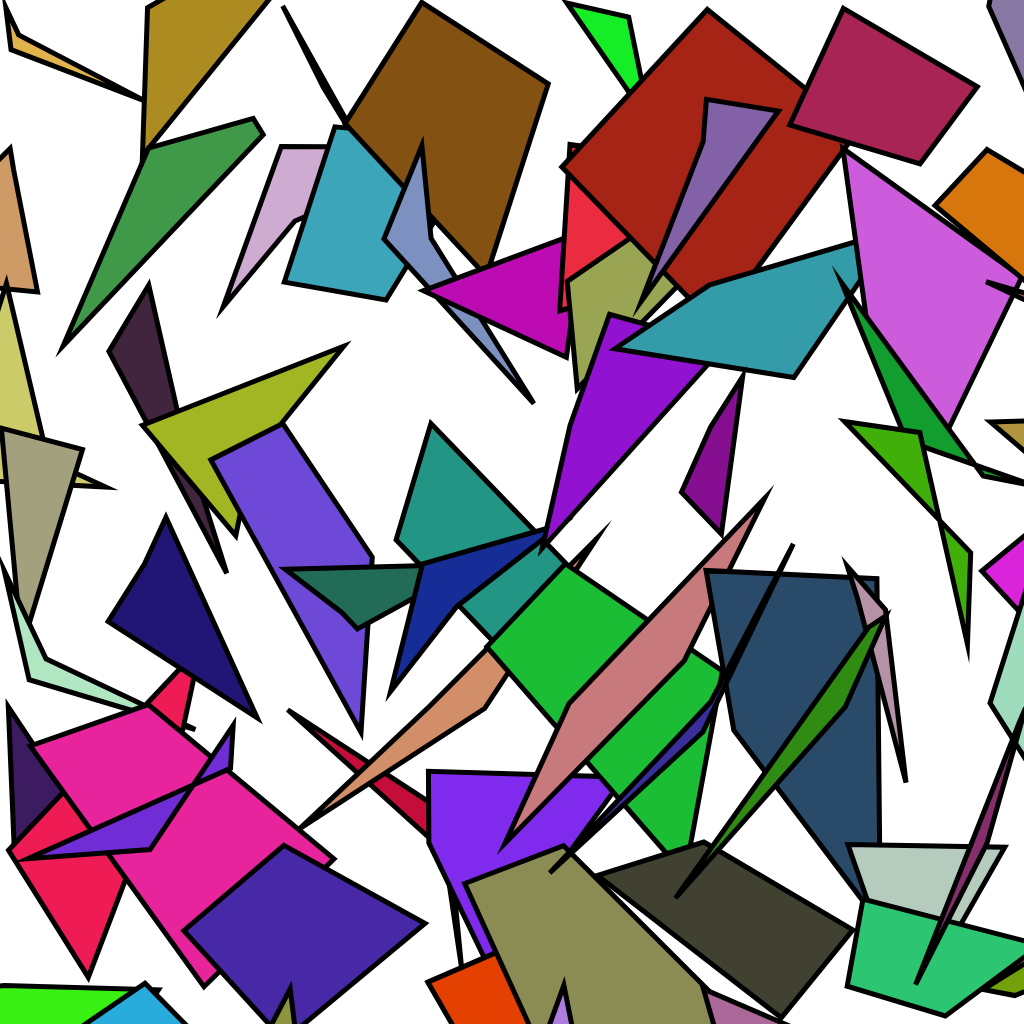
Cratere a campana, ceramica a figure rosse campane. Gruppo della Tenia.
Fino a epoca Romana, questo tipo di vaso non cessò d’essere uno degli utensili indispensabili nelle case. Nel dettaglio, questo cratere a figure rosse (su sfondo nero) è riccamente ornato ed è posto a decorazione di un corredo funebre in una tomba sannitica e il suo scopo era probabilmente beneaugurante al trapasso del defunto. Questo reperto è un manufatto di grande interesse storico perché testimonia che anche in queste terre, non colonizzate dalla civiltà greca, avevano un grande rilievo i miti, le tradizioni e le divinità elleniche. Questo Cratere ha una forma a campana rovesciata e con orlo svasato e presenta due anse orizzontali laterali per essere sollevato ed era rialzato su un piede con corto stelo. Questa tipologia di vaso ha origine nel periodo delle figure rosse, alla fine del IV secolo a.C.
Museo Civico Archeologico di Carife
Guttus



Questo oggetto è un Guttus ad anello (a vernice nera). La sua forma così particolare serviva a impreziosire questo contenitore riservato ad olii profumati e unguenti. Il beccuccio aveva lo scopo di versare il liquido sulla pelle senza sprecarne il prezioso e costoso contenuto. Siamo di fronte ad un oggetto il cui scopo poteva essere rituale o funzionale alla toilette femminile. Questa tipologia di reperto, riportato alla luce a Carife, è una produzione ceramica magnogreca, molto diffusa nel Sud Italia.
Più in generale Guttus, significa “vaso da cui il liquido fuoriusciva a goccia a goccia” [gutta in latino significa goccia] ed era usato per tanti scopi: tanto da biberon (guttus tintinnabula non è il caso di questo reperto) quanto da contenitore per il profumo (come in questo caso). Questo Guttus ha accompagnato per più di due millenni una fiera sannita nel suo viaggio nell’oltretomba ed ora lo possiamo ammirare in questo museo virtuale.
